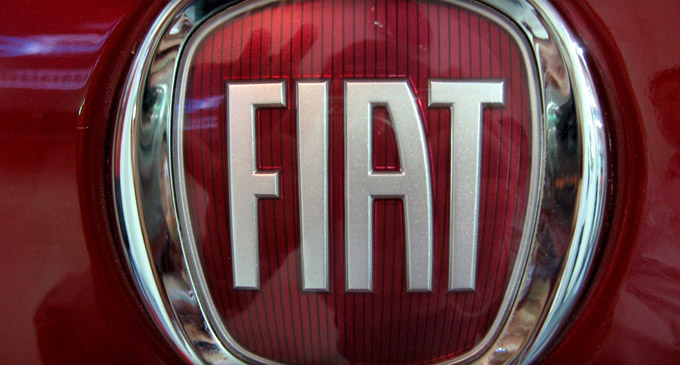L’Italia non è (più) un Paese per le aziende. Questo ha detto più volte e a chiare lettere Sergio Marchionne, numero uno di Fiat, coinvolto da tempo in una spinosa diatriba sindacale all’interno degli stabilimenti italiani del gruppo, col solito contorno di giudizi politici e sentenze della magistratura.
L’Italia non è (più) un Paese per le aziende. Questo ha detto più volte e a chiare lettere Sergio Marchionne, numero uno di Fiat, coinvolto da tempo in una spinosa diatriba sindacale all’interno degli stabilimenti italiani del gruppo, con il solito contorno di giudizi politici e sentenze della magistratura. Il manager un po’ ci è, e un po’ ci fa: non c’è dubbio che Fiat stia traslocando verso gli Usa, come già fatto dal settore macchine agricole (sede fiscale a Londra; legale ad Amsterdam; operativa nell’Illinois). E lo spostamento del cuore del gruppo ha ragioni economiche ben più solide dei litigi con la Fiom Cgil.
Ma ha certo gioco facile nel giustificare questo trasloco con l’enorme difficoltà di cambiare qualcosa nelle relazioni industriali, e in genere nella competitività che offre il sistema-Italia alle aziende. Né la politica, né il sindacato, né le rappresentanze datoriali, né la macchina dello Stato sembrano rendersi conto dell’assoluta necessità di cambiare marcia. Qui, invece, si persegue una strategia di piccolo cabotaggio, di provvedimenti minimi spacciati per riforme, di aperture così strette che si fatica pure a vederle; mentre la pessima burocrazia italiana sta incredibilmente dando il peggio di sé.
Un po’ ci si mette il legislatore, a complicare ove possibile le cose semplici o a rovinare le buone idee. Il pacchetto normativo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro o le regole sulla classe energetica degli immobili sono preclari esempi di come complicare la vita alle aziende, con tante inutili carte e maggiori costi.
Le articolazioni dello Stato italiano – notevoli e “pesanti” – d’altro canto non riescono a fare granché nel sostenere le nostre aziende alla conquista dei mercati stranieri. Francesi e tedeschi si muovono all’estero con alle spalle funzionari efficienti, una politica decisa, banche e finanza forti e presenti. Noi, in perfetta solitudine, quindi affrontando sempre una corsa ad handicap. Non riusciamo nemmeno ad approfittare dei tanti soldi che la Comunità europea ci mette a disposizione per lavori e progetti: i due terzi rimangono dove sono, ed è tutto dire in questo continuo piagnisteo di soldi che servono, soldi che mancano.
Insomma, stiamo completando il manuale di come non si affronta bene una forte crisi economica. La crisi finanziaria aveva quasi mandato a picco l’Irlanda, fino ad allora denominata la “tigre celtica”. Pochi ma drastici provvedimenti hanno rapidamente messo in carreggiata la macchina irlandese, secondo il valido principio che il malato grave non si cura con i brodini.
Ma è la stessa saggezza popolare a darci la strada giusta da seguire, non occorrono soloni politici o teorie economiche più o meno astratte. Quando il contadino si rende conto che il suo terreno produce di meno, s’ingegna per rimediare: un po’ di concime, una maggiore pulizia dalle erbe infestanti, la rotazione delle colture, nuovi metodi di coltivazione. Solo così potrà avere raccolti migliori.
Noi, invece, stiamo sul limitare del campo, gettandovi dentro un po’ di confusione, ulteriori litigi, moltissimi paroloni e infine tanta speranza che le cose si risolvano da sé, senza doverci per forza rimboccare le maniche e assumerci tutti le nostre responsabilità: Stato, imprenditori, sindacati, lavoratori. Ognuno invece è intento a guardare l’irresponsabilità dell’altro. È per questo che gli altri Stati stanno reagendo in qualche modo alla crisi, e noi no.