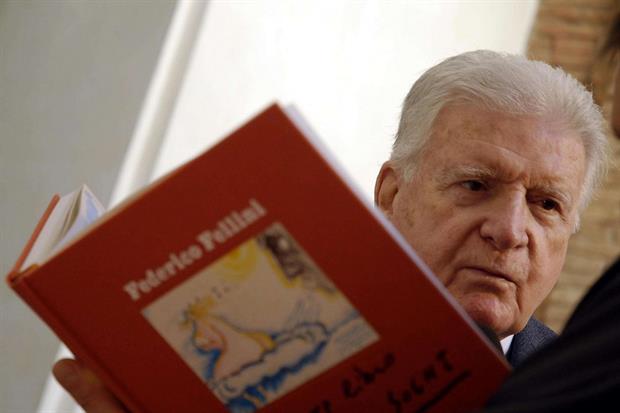Chiedo scusa se oggi in fondo parlo soprattutto di noi, di noi giornalisti. Ma un evento del tutto naturale e doloroso mi porta a farlo: Sergio Zavoli è morto e questo lutto ci riguarda profondamente. Confesso, però, che ho cercato di resistere alla tentazione di scrivere di lui – giornalista per davvero, e come pochi – e, dunque, del nostro strano e straordinario mestiere. Avevo – e ho ancora – paura di cadere nella retorica. Nulla di più facile, nulla di meno intelligente. Zavoli lo avrebbe forse accettato con pazienza e con un sorriso leggero dei suoi, senza darsene troppa pena, ma non lo merita.
Proverò, allora, a chinarmi appena, con affetto e rispetto sulla lunga parola scritta, detta, filmata e incarnata che è stata la sua vita di cronista, di cittadino, di intellettuale e di cristiano. Un uomo inquieto e pacato, capace di cercare e trovare senza perdere la voglia di cercare ancora, incapace – grazie a Dio – di dimenticare il proprio limite, ma libero e saldo nella consapevolezza della collettiva grandezza dell’umana condizione.
Quando nel 2015 gli proposi di tornare a scrivere, a novantadue anni suonati, ogni santo giorno e per tre mesi di fila, la rubrica che s’affaccia su questa prima pagina, provò a dire di no. Ma non gli riuscì. Un po’ per amicizia e molto per la condivisione profonda di tante nostre disarmate e forti battaglie informative dalla parte dei più deboli e dei senza voce, che apprezzava e commentava privatamente con me e interpretava pubblicamente con l’originalità, la libertà e l’elegante concretezza del suo stile.
Alla fine Sergio faticò a smettere, quasi gli costò chiudere quella sua e nostra “finestra” battezzata «Prima dei fatti». E poi non seppe e non volle più ricominciare. È l’unico serio cruccio di questi miei anni di direzione di “Avvenire”, ma in esso conservo anche la certezza del valore che ancora oggi rappresenta il dono di quel suo ultimo, breve e disteso riflettere nero su bianco, in un tempo in cui purtroppo tanti sono tornati a confondere il bianco e il nero, il bene e il male, e si tende a radicalizzare tutto, cancellando le infinite sfumature di colore che rendono affascinante l’esistenza, alimentano l’ansia di giustizia e di bellezza, sostengono la fiducia e la speranza.
A questo serve il nostro lavoro, ci ha prima dimostrato e poi ricordato Zavoli con la sua vita e la sua civile passione. Fare i giornalisti serve a vedere dentro la notte e in pieno giorno, anche quando tutto è talmente scuro o così abbacinante da sembrare indecifrabile. Nulla lo è mai del tutto, e la costanza rigorosa e indagatrice di un cronista, così come la forza delle analisi di chi ha idee chiare ma non arroganza, può aiutare gli uomini e le donne a riconciliare la cronaca in cui siamo immersi con la storia che possiamo e dobbiamo fare e di cui siamo parte. E tanto più quando questo è difficile, quando l’oscurità incombe, i sentimenti popolari sono tesi, la partigianeria (quella politica come ogni altra, persino nel paradiso perduto dello sport) distorce gli sguardi, storce le bocche e condiziona i giudizi.
Sergio Zavoli ha saputo fare fino in fondo questo lavoro umile e indispensabile. Lo ha fatto alla radio, in tv sui giornali, da reporter e da direttore. Lo ha fatto persino nella stagione del diretto impegno politico e del seggio in Parlamento. Lo ha fatto come pochi, anzi per certi versi come nessuno. Ed è riuscito a unire, nel suo lungo racconto della vita, l’alto e il basso, l’epica del sudore e il sussurro dello Spirito, la riflessione serrata e profonda sulle stagioni chiave della vita italiana e la rincorsa e la domanda arguta e popolana all’eroe del momento.
Del resto, come ha confessato pubblicamente nel 2017 in uno dei Seminari che organizzava alla Biblioteca del Senato, «siamo nati per essere l’umanità» e il «compito cruciale» di chi se ne rende conto e non se ne sgomenta «dovrà essere quello di conciliare e sciogliere le diversità per unirle, spenderle nel nome delle condivisioni, non delle separatezze».
Poteva ben dirlo, da uomo di pace qual era, e mai irenista. Incapace di sottovalutare le insidie incombenti, gli smarrimenti possibili, i cataclismi inevitabili, i ritornanti mostri. «Oggi, al pari di Ulisse, ognuno è in pericolo», ragionava e ci invitava a ragionare in questo «cambiamento d’epoca» che papa Francesco chiede di governare con amore e saggezza e di cui lui aveva acuta consapevolezza. E ci avvertiva sulla provvisorietà di ogni approdo che consideriamo definitivo: «Itaca non rappresenta la fine di un rischio, bensì la scelta concettuale del nostro sterminato cammino». Buon cammino nella luce, Sergio, amico mio, ora che questa notte è finita.
, direttore d Avvenire